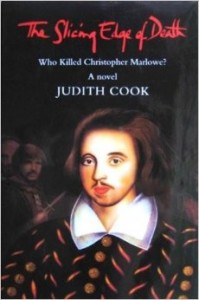teatro
teatro  Commenti disabilitati su E Luce Fu
Commenti disabilitati su E Luce Fu E Luce Fu
 È stato più o meno un secolo fa – o forse non proprio, ma di sicuro in un altro secolo.
È stato più o meno un secolo fa – o forse non proprio, ma di sicuro in un altro secolo.
Ero una ragazzina di belle speranze con una passione per il teatro, solo che non capivo granché. Credevo di voler recitare… Anyway, una sera un’insegnante ci porta tutti a vedere un Marivaux. Il Gioco dell’Amore e del Caso, diretto da Massimo Castri.
Bellissimo.
Tutto: regia, interpretazioni, scene, costumi… e luci.
Dopo più di vent’anni, quel che ricordo con precisione è come le luci della prima scena, ricreino meravigliosamente una mattinata estiva su una terrazza di pietra. E il resto a seguire. Niente colori, niente effetti particolari. Un uso di toni di bianco e – presumo – giallo per mostrare l’avanzare del giorno. E luci di taglio… Ah, le luci di taglio.
Vorrei ricordare chi fosse l’autore del disegno luci. So che i tecnici erano gente del CTB, ma l’autore? All’epoca nemmeno avevo ben chiaro che ci fosse qualcuno a disegnare le luci. Come ho detto prima, non capivo granché. Ma davvero, vorrei tanto averci badato, perché quello è stato il mio imprinting in fatto di luci. 
Ho impiegato del tempo ad accorgermene. Lustri, really. C’è voluto che smaltissi l’infatuazione per la recitazione. Che scrivessi un romanzo il cui protagonista fa gavetta da tecnico delle luci. Che smettessi di occuparmi di teatro. Che riprendessi da autrice. Che iniziassi una specie di gavetta mista assortita – un po’ assistente di regia, un po’ stage-manager*, un po’ tappabuchi… Non mi ricordo bene come sia arrivata alle luci, ma a un certo punto mi sono ritrovata ad avere funzioni semi-ufficiali connesse con le luci in generale, il disegno luci e la doma della gente alla consolle.
 E fin da subito ho tentato di ricreare quel che ricordavo a forza di bianco e di giallo e di arancione – e fin da subito ho scoperto che la curva di autoapprendimento in materia è ripida, ripida, ripida. Si va per tentativi ed errori. Molti tentativi e molti errori. Lavorare con una compagnia che non ha un teatro proprio e si sposta spesso aggiunge tutta una serie di affascinanti problemi. Di fatto, nella maggior parte dei casi vi ritrovate a lavorare con un gente di un service che non ha un briciolo di familiarità con il testo e tanta esperienza di teatro quanta se ne può mettere in equilibrio sulla lama di un coltello. Avreste bisogno di essere guidati – e invece dovete cercare la strada a tentoni e trascinarvi dietro un tecnico o due.
E fin da subito ho tentato di ricreare quel che ricordavo a forza di bianco e di giallo e di arancione – e fin da subito ho scoperto che la curva di autoapprendimento in materia è ripida, ripida, ripida. Si va per tentativi ed errori. Molti tentativi e molti errori. Lavorare con una compagnia che non ha un teatro proprio e si sposta spesso aggiunge tutta una serie di affascinanti problemi. Di fatto, nella maggior parte dei casi vi ritrovate a lavorare con un gente di un service che non ha un briciolo di familiarità con il testo e tanta esperienza di teatro quanta se ne può mettere in equilibrio sulla lama di un coltello. Avreste bisogno di essere guidati – e invece dovete cercare la strada a tentoni e trascinarvi dietro un tecnico o due. 
Aggiungete il fatto che per la prova tecnica non c’è mai – ma mai tempo. O meglio, magari il tempo ci sarebbe, ma viene sempre fagocitato da attori e registi in cerca della perfezione ultima. E voi potete strillare, supplicare, piangere, minacciare quanto volete: ci si riduce sempre a fare i puntamenti al galoppo nell’ultimo quarto d’ora disponibile, con gli organizzatori che vi fiatano sul collo perché è troppo tardi, bisogna iniziare, iniziare, iniziare, e avete avuto tutto un pomeriggio per questa roba…
Questa roba.
Poi leggete cose come Backstage di Judith Cook, e spargete lacrime di consolazione nello scoprire che i problemi sono esattamente gli stessi alla Royal Shakespeare Company – solo su scala sesquipedalmente più vasta… Ma in realtà, mentre cercate di improvvisare una variazione e spiegare quel che va fatto durante i frettolosissimi puntamenti, i guai della RSC sono l’ultimo dei vostri pensieri.
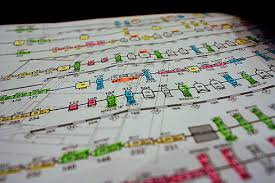 Aggiungete poi l’infelicità di ritrovarvi con un impianto luci in cui non si può fare assolutamente nulla perché il suo funzionamento si riassume in acceso/spento. Oppure un impianto luci che consiste di coppie di faretti fissi nelle delicate sfumature puffo, anas, sangue di bue, sciroppo-di-menta e itterizia e ah-ma-i-cursori-mica-funzionano. Oppure un impianto che consente di variare tra diciotto colori fissi pensati per i concerti rock e un gazillione di sfumature intermedie, ma non c’è tempo per cercare e fissare quelle giuste, e in fondo il-giallo-è-giallo…
Aggiungete poi l’infelicità di ritrovarvi con un impianto luci in cui non si può fare assolutamente nulla perché il suo funzionamento si riassume in acceso/spento. Oppure un impianto luci che consiste di coppie di faretti fissi nelle delicate sfumature puffo, anas, sangue di bue, sciroppo-di-menta e itterizia e ah-ma-i-cursori-mica-funzionano. Oppure un impianto che consente di variare tra diciotto colori fissi pensati per i concerti rock e un gazillione di sfumature intermedie, ma non c’è tempo per cercare e fissare quelle giuste, e in fondo il-giallo-è-giallo…
Avete presente tentare di riprodurre un acquerello con un pacchetto di evidenziatori?
Ecco.
E voi magari avete letto in proposito, e avete affrontato il corso online di lighting-design del MIT, e pianto un pochino di fronte a diagrammi pensati per il Metropolitan. E nondimento sognate di poter lavorare per una volta – una volta – con due americane di tagli e piazzati… 
E poi un po’ per volta cominciate a capire con quale service preferite lavorare, e i tecnici si abituano a voi e alle vostre eccentriche richieste, e acquisite quel tanto di prepotenza che serve per ritagliare mezza prova tecnica ogni tanto, e fate ancora un sacco di errori e di tentativi, e ogni volta imparate qualcosa di nuovo, e rischiate alternativamente l’omicidio e il linciaggio, e studiate, e ogni tanto capita che vi piazzino a una consolle da soli, e qualche volta va bene e qualche volta no – ma non importa.
O meglio, importa eccome, ma non vi ferma affatto, e voi… voi continuate imperterriti a sperimentare con i tagli (ah, i tagli!), a chiedere del bianco caldo, del giallo giusto e dell’arancione, e adorate quando si recita all’aperto e si può avere un pochino di fuoco in scena, e strologate su Pinterest, e vi cercate un nonnulla di apprendistato…
 Perché in fondo la vostra è una quête – alla ricerca della luce del sole.
Perché in fondo la vostra è una quête – alla ricerca della luce del sole.
_____________________________________________________
* Nulla di amministrativo. Lo stage manager (o direttore di palcoscenico) se ne sta dietro le quinte, risolve problemi e tiene insieme le cose con il nastro isolante e le spille da balia.