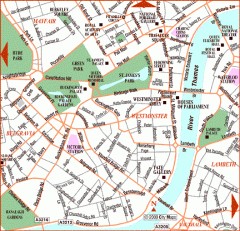Oggi Tecnica
Oggi Tecnica  2 Comments
2 Comments I’ve got rhythm…
Ho la vaga impressione di avere già citato Virginia Woolf a proposito del ritmo, ma credo che lo ripeterò comunque. A memoria, e quindi senza la minima pretesa di precisione: scrivere un libro è quasi solo questione di ritmo. Una volta scelto un ritmo, il libro viene da sé.
Sì, vabbe’.
Premesso che per una volta non credo affatto a Virginia, dirò tuttavia che il ritmo della prosa è fondamentale a vari livelli. Narrativamente, il ritmo serve a rallentare o accelerare il tempo di una scena; musicalmente, per dir così, il ritmo delle frasi cattura, trascina, culla, mette a disagio o strangola il lettore. I cambi di ritmo sottolineano o preparano le sorprese, enfatizzano gli snodi della trama, sostengono le descrizioni… ci sono un sacco di cose che si possono fare amministrando con saggezza il ritmo di ciò che si scrive. Ci sono un sacco di modi per amministrare saggiamente il ritmo.
Oggi mi soffermo su uno in particolare, perché quando mi è stato fatto notare mi ha lasciata perplessa. Perplessa, perché dire che un susseguirsi di frasi brevi rallenta il ritmo, mentre un’unico periodo lungo lo velocizza, a me sembra controintuitivo. Insomma, una frase breve è lapalissianamente più rapida, no? E il ritmo di tre o quattro frasi brevi in rapida successione deve necessariamente correre, giusto?
No, sbagliato.
Provate a immaginare ogni punto come un semaforo rosso, e vedrete che un paragrafo costituito da un numero qualsiasi di frasi brevi separate da punti è una strada piena di semafori rossi. Ogni volta occorre fermarsi.
Prendiamo un esempio da Close Range, di Annie Proulx*, autrice americana celebre per i suoi periodi interminabili**:
Cenarono tardi, accanto al fuoco, una scatola di fagioli per ciascuno, patate fritte e un quarto di whiskey in due, seduti contro un tronco, con le suole e i risvolti dei jeans a scaldare, passandosi la bottiglia mentre il cielo lavanda perdeva colore e l’aria fredda scendeva, bevendo, fumando, col fuoco che gettava scintille nella curva del torrente, buttando legna sul fuoco per tenere viva la conversazione, parlando di cavalli e di rodeo, di donne, incidenti e ferite subite, del sottomarino Threscher perduto due mesi prima con tutto l’equipaggio e di come doveva essere stato negli ultimi minuti prima della fine, di cani che ciascuno aveva avuto e conosciuto, della siccità, del ranch dove i genitori di Jack tiravano avanti, della casa di famiglia di Ennis, perduta anni addietro dopo la morte dei suoi, del fratello maggiore a Signal, della sorella sposata a Casper.
Monster period di 145 parole, se non ho contato male, eppure provate a leggerlo ad alta voce: è scorrevolissimo e veloce. All’inizio c’è il verbo all’indicativo che indica l’azione principale, completata poi da una serie di gerundi che scandiscono le azioni accessorie e l’accumularsi dei dettagli, fino all’elenco degli argomenti toccati nella conversazione, che passano dal triviale al tragico al personale. Il tutto regolato da tutta una processione di virgole. Ma le virgole non fermano: anziché semafori rossi, sono boe, attorno alle quali scivoliamo lungo la traiettoria di una scena di dialogo indiretto.
Spero che la signora Proulx non me ne voglia se adesso modifico sperimentalmente il suo periodo, spezzettandolo.
Cenarono tardi, accanto al fuoco. Mangiarono una scatola di fagioli per ciascuno, patate fritte e un quarto di whiskey in due. Sedevano contro un tronco, con le suole e i risvolti dei jeans a scaldare, passandosi la bottiglia mentre il cielo lavanda perdeva colore e l’aria fredda scendeva. Bevvero e fumarono, col fuoco che gettava scintille nella curva del torrente, buttando legna sul fuoco per tenere viva la conversazione. Parlarono di cavalli e di rodeo, di donne, incidenti e ferite subite. Chissà come, da quello passarono al sottomarino Threscher perduto due mesi prima con tutto l’equipaggio. Si domandarono come doveva essere stato negli ultimi minuti prima della fine. Poi fu la volta dei cani che ciascuno aveva avuto e conosciuto, della siccità. Jack parlò del ranch dove i suoi genitori tiravano avanti. Ennis raccontò della casa di famiglia, perduta anni addietro dopo la morte dei suoi, del fratello maggiore a Signal e della sorella sposata a Casper.
Visto? Lo so che controintuitivo, l’ho sempre pensato, e una parte di me lo pensa ancora, anche davanti all’evidenza: ogni singola frase della seconda versione può essere asciutta e rapida, ma l’effetto complessivo del paragrafo diventa molto più lento, con tutte quelle pause obbligate. Se volete fare un esperimento, leggete ad alta voce entrambe le versioni, o fatevele leggere da qualcun altro, o registratevi e riascoltate. Il ritmo è cambiato, molto più spigoloso e più faticoso alla lettura.
Il problema è che costruire periodi come la versione originale, spropositatamente lunghi e traboccanti di dettagli, e tenerli scorrevoli, è un’arte complicata, richiede orecchio, attenzione e pratica, padronanza della sintassi e la pazienza di tornare indietro e limare, spostare, leggere ad alta voce ancora e ancora, fino a quando ritmo, musica e significato non si combinano in maniera liscia.
Difficile, ma non c’è niente come provare. E a dire il vero, credo che sperimentare una tecnica controintuitiva sia tanto più efficace proprio perché ci costringe ad affrontare i preconcetti, a provare soluzioni che non avevamo considerato (e magari credevamo di non dover considerare affatto), a pensare con estrema attenzione a ogni parola, ogni suono, ogni virgola che usiamo.
Quindi, non so voi, ma io, nel corso delle numerose ore di treno che mi aspettano durante il fine settimana, ho intenzione di dedicarmi a questo esercizio: partire dal monster period di Annie Proulx e riscriverlo, modificandolo vieppiù nel contenuto, ma mai nella struttura. Centocinquanta parole e nemmeno un punto, again and again, fino a quando non riesco a farlo indipendentemente dal modello e con scioltezza accettabile e buon ritmo.
Non intendo certo modificare il mio stile in una processione di periodi di dimensione biblica, ma voglio saperne scrivere uno senza sfigurare, se ne sorge l’occasione o la necessità.
__________________________________________________________________________
* Per la cronaca, è il racconto da cui è stato tratto I Segreti di Brokeback Mountain.
** Traduzione mia: nulla di artistico, solo funzionale.
__________________________________________________________________________
Tengo a precisare che questo post è stato scritto in uno stato di terror panico, perché c’è un r (bestia con otto zampe) che se ne va in giro tra l’una e l’altra cassa del computer. E siccome ho già chiamato la Cavalleria dieci minuti fa per estrometterne un altro, e non ho il coraggio di ripetere il numero, posso solo cercare di finire il prima possibile e allontanarmi in fretta. Per cui non c’è stata gran revisione, e se trovate un numero di errori di battitura superiore al consueto, blame it on the spider.