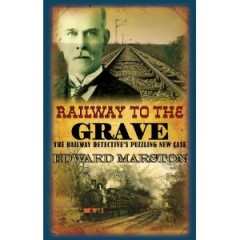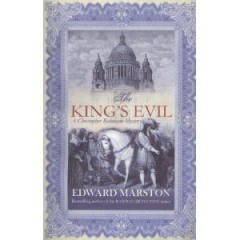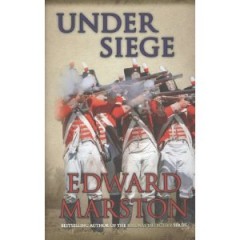Oggi Tecnica, teatro, Vitarelle e Rotelle
Oggi Tecnica, teatro, Vitarelle e Rotelle  4 Comments
4 Comments Ad Alta Voce E Con Le Cesoie In Mano
Era un po’ di tempo che non si parlava di tecnica, ma nel giro di pochi giorni mi è capitato un paio di volte di sentirmi dire (o implicare) che scrivere teatro è “più facile”, perché in fondo si tratta solo di scrivere dialoghi.
Perché a proposito dei dialoghi vige questo bizzarro mito: be’, quanto può essere difficile scrivere dialoghi? È la forma di linguaggio con cui tutti abbiamo, per forza di cose, più dimestichezza, no? Tutti parliamo, tutti usiamo il dialogo ogni giorno… ergo, scrivere dialoghi è facile.
Ebbene, no. È vero che tutti usiamo quotidianamente il dialogo, ma basta provare a trascrivere verbatim un pezzo qualsiasi di conversazione per accorgersi di che differenza abissale ci sia tra quel che si dice e un buon dialogo letterario – o teatrale.
Per prima cosa, trascrivendo, ci si rende conto che Nella Vita Quotidiana si dicono (e ripetono) un sacco di cose irrilevanti, sciatte e vacue, che per iscritto si condensano, rendono coerenti e intelligibili – possibilmente conservandone efficacia e sapore. Randy Ingermanson dice che il buon dialogo è pesce già sfilettato: solo le parti buone. Non si tratta di riprodurre pari pari il modo in cui parlano le persone, ma di trovare il giusto equilibrio tra realismo, registro ed efficacia, e servirsene per convogliare soltanto informazioni rilevanti.
Tutto quello che si mette sulla pagina deve servire a caratterizzare un personaggio e/o far avanzare la storia – possibilmente entrambe le cose. Ogni battuta di dialogo che non svolge almeno una di queste funzioni… a questo punto dovrei dire “va eliminata”, ma mi limiterò a qualcosa di meno drastico. Ogni battuta di dialogo che non svolge almeno una di queste funzioni, non ha una ragione narrativa per essere dov’è. Non è sempre facile. Personalmente, devo continuare a impormi di potare tutto ciò che è soltanto decorativo – non importa quanto mi piaccia. E non sempre ci riesco. A volte, nel tentativo di rendere rilevante qualcosa che mi piace troppo per poterci rinunciare, sono capace di dissennati equilibrismi, fino al momento in cui mi rendo conto che sto facendo John&Iris – e allora taglio tutto quanto, e in genere la scena ne guadagna.
Ma questo non mi rende necessariamente più saggia per la prossima volta.
Oh, e John&Iris è lessico famigliare per l’eccesso opposto al chit-chat decorativo, quando si lardella il dialogo di informazioni non plausibili. Può essere necessario informare il lettore sul rapporto tra il narratore, John e Iris, e del fatto che sono passati tre mesi dalla scena precedente, ma non per questo si può far esclamare al narratore “Buongiorno John, mio vecchio e fraterno amico! E come sta tua moglie Iris in questa splendida giornata di giugno?” In molti romanzi in cui una tecnica di qualche genere – non importa se si tratti di sottomarini, procedura legale, arazzi o curling – gioca un ruolo, capita di trovare lunghe pagine di dialogo in cui due o più personaggi si scambiano dettagliate informazioni su particolari che dovrebbero già conoscere a menadito. Ricordate il Comandante Phillips e la Regola del Sottomarino Nucleare?
Dopodiché trovare (e mantenere) la giusta combinazione di efficacia e plausibilità è tutt’altro che facile: è una questione d’orecchio, buon senso e intuito in parti variabili.
Io trovo utili due metodi – e li sto usando parecchio per la seconda stesura del Play Senza Titolo – di cui magari state seguendo le vicende via bollettini notturni. In primo luogo, mi leggo i dialoghi ad alta voce. Meglio ancora sarebbe farseli leggere da qualcuno – se avete una o due persone pazienti e disponibili, e so di gente che fa da sé, si registra e riascolta. Ora non dico che sia a prova di bomba, ma nove volte su dieci, se c’è, la magagna viene a galla.
Ma prima, o dopo, o prima e dopo, prendo la mia scena e fingo con convinzione di poterne tenere solo due terzi*. A che cosa proprio non si può rinunciare? È divertente quasi come farsi estrarre i denti del giudizio – ma la maggior parte delle volte, potato di fioriture, svolazzi e quisquilie varie, il dialogo ne esce più affilato, più efficace e più vivido.
Per cui, no: non c’è niente di facile nello scrivere dialoghi, thank you very much. È roba da liutai, una di quelle faccende di orecchio, precisione, tecnica, pazienza, numerose fasi e, tanto per cambiare, un sacco di lavoro.
_________________________________________
* O tre quarti – anche se conosco anime avventurose e drastiche, che riducono alla metà.