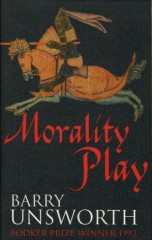grilloleggente, Oggi Tecnica
grilloleggente, Oggi Tecnica  2 Comments
2 Comments Entered From The Sun – Pag. 145
Sì, dopo tutto non l’ho piantato lì, e dopo tutto anche il Capitano Barfoot è stato incaricato da altra gente (davvero?) di indagare sulla morte di Marlowe. A differenza di Hunnyman, Barfoot non accetta per paura o per avidità, ma perché è incuriosito e per proteggere gli interessi della sua famiglia. Tra parentesi, è vieppiù chiaro che Hunnyman è un caso senza speranza: un buon ragazzo che si crede molto più astuto e più cinico di quanto sia, alla completa mercé sia della vedova che del suo misterioso datore di lavoro – chiamiamolo Tom, per il momento. I have a fondness per Tom Walsingham, anche se forse nel 1597 non sarebbe stato considerato così giovane da descriverlo sempre come “un giovanotto”. E chiunque egli sia, il suo giudizio in fatto di investigatori è suscettibile di dibattito…
Ma non è di questo che volevo parlare.
Quello che mi fa diventare matta in questo libro sono i punti di vista. Tutto è cominciato con una narrazione in III persona a punti di vista alternati: Hunnyman, poi Barfoot, poi Hunnyman, occasionalmente Alysoun… salvo che poi ogni tanto s’infila altra gente, come un misterioso narratore in I persona che all’inizio si è presentato come “nulla più che un fantasma”, poi ha cominciato a sconfinare nei capitoli di Barfoot, e io credevo che fosse uno sporadico intervento autoriale, ma adesso sono sicura che non è così. Costui salta fuori ogni tanto come un pupazzo a molla, fa considerazioni e digressioni, moraleggia e ipotizza, si rivolge al lettore – why, in almeno un’occasione, per un po’, identifica il lettore con Barfoot… E quando il discorso si fa indiretto, a volte sembra essere lui che ascoltiamo.
Un fantasma… che sia Marlowe? Ma no: da un lato, l’autore ha descritto tutti i personaggi come fantasmi; dall’altro il narratore in I persona (che non è l’autore) ha elencato i personaggi comprendendo sé stesso e Marlowe (che in questa storia non avrà molto da dire per sé) come entità distinte. Ossignor!
A scuola c’insegnano a limitare funzionalmente i punti di vista. Ad essere molto cauti nel mescolare I e III persona (e ad evitare la II come la peste); ad essere coerenti nei tempi verbali; e soprattutto a non confondere il lettore – mai – e a non permettere che la scrittura abbia il sopravvento sulla storia. Ebbene, con Garret non ho mai la più pallida idea di chi parlerà nella pagina successiva – e ho smesso di considerare significativi i titoli dei capitoli), mi trovo chiamata in causa come in conversazione nei momenti più inaspettati, vengo sbalzata continuamente dall’immediatezza colloquiale del presente al distacco apparente del passato remoto, dal discorso diretto (come usa nei romanzi) al discorso indiretto caricato di ulteriori strati di significato, mi ritrovo a sbirciare le lettere di Barfoot per suo fratello, e per di più mancano deliberatamente un sacco di pronomi.
Sono confusa? Un pochino, a volte, ma non tanto quanto mi pare che dovrei esserlo nelle circostanze. Noto troppo la scrittura? La noto di sicuro, ma con golosa delizia. Il notarla mi trascina fuori dalla storia? No, accidenti, no! In qualche misterioso, alchemico, invidiabile modo, questa scrittura fa parte della storia, o forse è la storia… o quanto meno, è congegnata in modo tale da non farmi notare l’allarmante particolare che la storia in realtà non c’è.
Perché siamo, per l’appunto, a pagina 145 e non è ancora successo un bottone. O almeno pochi bottoni. A parte il fatto che Hunnyman spera di sistemarsi con la vedova e Barfoot aiuta segretamente i missionari gesuiti, ci sono le due indagini, ed è vieppiù evidente che, se qualcuno può scoprire qualcosa, quello è Barfoot, che sa come muoversi per le cancellerie, ungere le ruote giuste (o pizzicarle con la punta di un coltello), dissotterrare informazioni dai posti più improbabili. A parte questo, zero. In circostanze normali sarei furibonda e avrei già abbandonato la lettura. E’ chiaro che la scrittura iridescente, imprevedibile e densa di Garret non è una circostanza normale.
E non solo voglio continuare a leggere: voglio provare a fare altrettanto, cribbio!