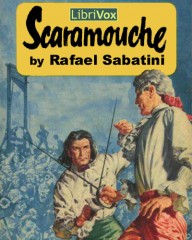Tutti abbiamo, almeno una volta, scosso il capo con un sorrisino indulgente all’indirizzo dell’anziana zia che guardava con gli occhi lustri i (probabilmente finti) ricongiungimenti famigliari carrambati dalla Carrà – vero?
Quanto meno, io usavo scuotere il capo eccetera, e mancavo di considerare come, in fondo, la Raffaella e i suoi autori non facevssero altro che giocare sull’eterno appeal di uno dei tòpoi più immarcescibili della letteratura: l’agnizione.
Ovvero il protagonista che scopre di essere qualcun altro. Oppure scopre che qualcun altro è qualcun altro ancora – spesso (ma non sempre) discendente, ascendente, agnato o cognato.
Talmente immarcescibile che Aristotele già lo teorizzava come venerando, infallibile e superiore a qualsiasi altro meccanismo tragico e, ventiquattro secoli più tardi, ci intratteniamo ancora – e con pieno successo – le vecchie zie al sabato sera.
Aristotele aveva in mente, a titolo archetipico, Edipo – che dopo aver fatto fuori un re e averne impalmato la vedova, scopre che si trattava dei suoi genitori. Ops.
Dove si vede che l’agnizione non è necessariamente un lieto fine. Non ci è dato di sapere cosa Aristotele ne pensasse quando era usata a fini men che truci, ma la Commedia Attica è piena di esempi di fanciulle immaritabili che si scoprono essere bennate eredi di cospicue fortune – e quindi perfette per l’innamorato di buona famiglia…
Vi pare di avere già sentito questa storia? Small wonder, perché è onnipresente. Si può dire che non ci sia corpus di miti o folklore senza agnizione, nel bene e nel male. Pelle d’Asino e la Piccola Guardiana d’Oche sono principesse in disguise, il Brutto Anatroccolo non è un’anatra affatto, gli orfani non sempre sono orfani come sembrano, le fiabe russe traboccano di baldi giovanotti che si scoprono figli dello Zar – al punto che Popp cataloga il Disvelamento dell’Eroe tra le sue funzioni – e non cominciamo nemmeno a parlare di fate, streghe e creature magiche in generale che se ne vanno attorno sotto mentite spoglie fino al dénouement.
E naturalmente la letteratura non poteva – né si vede perché avrebbe dovuto – sottrarsi al fascino del tòpos. Dopo tutto, segreti, identità perdute, misteri e ammenicoli del genere sono la materia di cui son fatte le storie. La citazione semi-shakespeariana serve a introdurre Il Racconto di’Inverno e la very aptly named Perdita, un’altra pastorella che si ritrova principessa. Non posso fare a meno di considerare un’agnizione anche la faccenda di MacDuff, che MacBeth scopre non essere tecnicamente nato da donna, e quindi oggetto inopinato della predizione delle streghe… Non bisognerebbe mai prendere gli oracoli alla lettera, ma questa è un’altra storia.
L’agnizione, per la sua inevitabile natura di colpo di scena, ha una seria carriera a teatro – pensate a Molière e a Beaumarchais, con le rivelazioni della penultima scena che impediscono matrimoni combinati e precipitano tutti verso il lieto fine – ma chi va veramente a nozze con questo tòpos sono i romanzieri ottocenteschi – e i librettisti d’opera.
Gavroche è figlio dei Thénardier, Esmeralda non è affatto una zingarella, Isabella di Vallombrosa non è orfana né attrice girovaga, il Signore Indiano in realtà è l’amico che ha involontariamente rovinato il babbo di Sara Crewe, Mrs. Milligan è la madre di Rémy, la pazza nella soffitta è la moglie di Mr. Rochester, il reverendo Rivers è il cugino di Jane Eyre, Mrs. Pryor è la madre di Caroline, Milady è la moglie di Athos, Redgauntlet è lo zio di Darsie Latimer, Ebenezer Balfour è il fratello minore del padre di David, Rogiero è figlio di Re Manfredi*, il Conte di Montecristo è Edmond Dantès, il vecchio Burgravio e la “strega” Gwenhyfara sono i genitori del giovane Spadaceli**…
Noterete che non ho citato Dickens. Non l’ho citato perché Dickens è non solo il festeggiato quest’anno, ma si trova in una categoria a sé in qualità di spudorato specialista dell’agnizione. Consideriamo solo The Adventures of Oliver Twist. Oliver, orfanello in una città innominata, giunge a Londra e, fra un milione abbondante di persone, s’imbatte senza saperlo nel mancato sposo della defunta sorella del suo defunto padre. Basta? No, non basta. Oliver si ritrova nelle grinfie di pessima gente, che se lo trascina dietro in una rapina con scasso. E chi è la derubata? La zia adottiva di Rose, l’ignara sorella minore della defunta (e nubile) madre di Oliver. Basta? Ancora no. Giusto per non farci mancare nulla, la pessima gente non tormenta Oliver per caso, ma perché imbeccata dal malvagio figlio legittimo del defunto padre di Oliver, e (a riprova del fatto che nulla cambia veramente attraverso i millenni) Rose non può sposare l’amato e innamoratissimo cugino adottivo a causa dell’ombra che grava sulla sua nascita. Poi tutto converge in un terz’ultimo capitolo che è un’orgia di agnizioni, contro-agnizioni, adozioni, rivelazioni e richieste di matrimonio, in uno sfoggio di sprezzo del ridicolo tale da far impallidire un librettista d’opera.
Perché siamo sinceri: in confronto, Arrigo che si scopre figlio del tirannico duca di Monforte mentre Monforte cade sotto i colpi dei ribelli siciliani, o il Conte di Luna che individua il fratello perduto proprio nel trovatore che ha appena fatto giustiziare, o Lucrezia Borgia che – dopo tutto – è madre di Gennaro, o Maria/Amelia che si ritrova figlia del Doge, son cose da nulla – agnizioncelle veniali.
Agnizioncelle veniali sulle quali finivano con l’inciampare anche autori insospettabili. Prendete Oscar Wilde. Proprio lui, che aveva detto che ci voleva un cuore di pietra per non ridere leggendo la scena della morte di Little Nell, che cosa combina in A Woman Of No Importance? Infila una scena in cui il Bravo Ragazzo spicca il balzo per sfidare a duello il Grand’Uomo Arrogante – ma la Madre del Bravo Ragazzo si frappone al grido di “Gerald, No! È tuo padre!” Qualcuno – non so più chi, presumo un critico – disse che Wilde meritava che un’illustrazione a colori di questa scena venisse affissa in tutte le pubbliche piazze, ad eterno disdoro del suo autore. Wilde non dovette prendersela troppo – o forse se la prese proprio tanto, perché l’anno successivo se ne uscì con The Importance of being Earnest, che fra l’altro era una pungente, perfetta parodia di tutte le convenzioni in fatto di agnizione…
E il fatto è che, undici volte su dieci, l’agnizione si regge su coincidenze e improbabilità assortite che i contemporanei di Aristotele non avevano remore nel giustificare con il Fato, il volere degli dei e l’inaffidabilità degli oracoli, ma oggi?
Verrebbe da pensare che in quest’epoca di lettori smaliziati, gli autori rifuggano l’agnizione come un principio di pleurite doppia resistente agli antibiotici…
E invece no. Saremo anche lettori smaliziati, O Contemporanei, ma l’agnizione prospera imperterrita nella letteratura di genere, al cinema, in televisione e nell’immaginario collettivo – come dimostrano Guerre Stellari, Harry Potter, La Bussola d’Oro, Hugo Cabret, il Dr. House e Raffaella Carrà.
Il fatto è che al Lettore (in senso lato) piacciono gl’indovinelli, i segreti, gli scambi in culla, tutto ciò che non è quel che sembra. Ai lettori piace l’idea che chiunque possa non essere chi dice di essere. O chi gli è stato insegnato a credere di essere. Ai lettori/spettatori piace commuoversi sulla vecchietta che ritrova la sorella emigrata in Brasile cinquant’anni prima e mai più sentita. Adorano singhiozzare quando, dal biplano abbattuto, anziché un pilota tedesco viene estratto il migliore amico del protagonista***. Si sciolgono quando qualcuno – chiunque – si ritrova meno orfano di quanto tutti credessimo.
D’accordo – probabilmente questa faccenda degli orfani andrebbe qualificata****, ma in linea generale, se è vero che la via più sicura per il cuore del lettore sono i legami affettivi, e che indovinelli e sorprese catturano la mente del lettore come nient’altro, forse Aristotele non aveva tutti i torti: l’agnizione – sorpresa affettiva nel bene o nel male – è proprio un buon meccanismo narrativo.
_____________________________________________________
* Cosa che scoprono ritrovandosi la sera della battaglia di Benevento, quando entrambi sono feriti a morte. Molto opportunamente, il malvagio è a portata di mano, pronto a spiegare come Rogiero abbia tradito Manfredi credendolo suo rivale in amore… Poi entrambi muoiono. Anche Guerrazzi non scherzava. 
** In realtà, a ben pensarci, tutto – ma proprio tutto – il teatro di Hugo si fonda sull’agnizione. Non c’è un suo dramma in cui la gente sia quel che gli altri credono.
*** Caramelle virtuali a chi riconosce il film…
**** È del tutto possibile, lo ammetto, che gente come Esther Summerson e Luke Skywalker abbia altre preferenze in fatto di tòpoi narrativi. Ma è gente immaginaria, la cui opinione non conta poi troppo.
 anglomaniac, musica, teatro
anglomaniac, musica, teatro  2 Comments
2 Comments  Ci sono le zitelle, ci sono le sventate, ci sono le sventurate, ci sono quelle di cattivo carattere, ci sono le perdute (non molte), ci sono le deliziose e poi ci sono le angeliche – ma Dickens ci caccia sempre qualche ragazza da marito. Ed è solo ovvio: come immaginare un romanzo ottocentesco senza una ragazza da marito?
Ci sono le zitelle, ci sono le sventate, ci sono le sventurate, ci sono quelle di cattivo carattere, ci sono le perdute (non molte), ci sono le deliziose e poi ci sono le angeliche – ma Dickens ci caccia sempre qualche ragazza da marito. Ed è solo ovvio: come immaginare un romanzo ottocentesco senza una ragazza da marito? 
 Delle emanazioni di Maria Beadnell abbiamo già detto, ma parliamo di quelle di Mary Hogarth, la cognatina dell’autore, morta a diciassette anni e immortalata nell’insostenibilmente angelica Little Nell. Nell è una di quelle ragazzine troppo dolci per vivere, sventurata per quattro, tenera, saggia, affettuosa, paziente e mite e coraggiosa e pia… E come Mary, muore giovane e semi-santa in una scena che, come diceva Oscar Wilde, bisogna avere un cuore di pietra per non riderci su. Ma di Mary ci sono altri ritratti, dolci, sventurate e pazienti fanciulle come Kate Nickleby, Lizzie Hexam o Rose Maylie.
Delle emanazioni di Maria Beadnell abbiamo già detto, ma parliamo di quelle di Mary Hogarth, la cognatina dell’autore, morta a diciassette anni e immortalata nell’insostenibilmente angelica Little Nell. Nell è una di quelle ragazzine troppo dolci per vivere, sventurata per quattro, tenera, saggia, affettuosa, paziente e mite e coraggiosa e pia… E come Mary, muore giovane e semi-santa in una scena che, come diceva Oscar Wilde, bisogna avere un cuore di pietra per non riderci su. Ma di Mary ci sono altri ritratti, dolci, sventurate e pazienti fanciulle come Kate Nickleby, Lizzie Hexam o Rose Maylie.