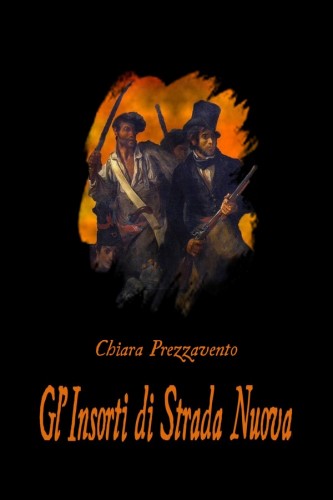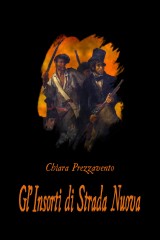C’era una volta, un paio di anni fa, una lettrice (ed ex collaboratrice, se ho ben capito) di Historical Novels Review, che scrisse alla rivista una lettera furibonda, sollevando la questione di che cosa fosse di preciso un romanzo storico – e di che cosa invece non lo fosse affatto. Il romanzo storico è un genere ben definito, sosteneva la signora in questione, al quale non appartengono romanzi rosa in costume, fantasy a sfondo storico, viaggi nel tempo, ucronie e via dicendo.
C’era una volta, un paio di anni fa, una lettrice (ed ex collaboratrice, se ho ben capito) di Historical Novels Review, che scrisse alla rivista una lettera furibonda, sollevando la questione di che cosa fosse di preciso un romanzo storico – e di che cosa invece non lo fosse affatto. Il romanzo storico è un genere ben definito, sosteneva la signora in questione, al quale non appartengono romanzi rosa in costume, fantasy a sfondo storico, viaggi nel tempo, ucronie e via dicendo.
HNR, rivista angloamericana specializzata, seguiva e segue una politica molto aperta in materia, e rispose alla lettrice sostenendo che negli ultimi anni la definizione del genere si era allargata a comprendere un certo numero di sottogeneri, la cui natura varia selvaggiamente. Fenomeno difficile da ignorare – ma soprattutto, si chiedeva il redattore nella risposta, era saggio e lungimirante volerlo ignorare?
Non è un caso che la discussione sia nata in ambito anglosassone, nel contesto di un mercato editoriale molto più segmentato del nostro, ma l’argomento è interessante. Al di là della politica editoriale di HNR, è assolutamente vero che il romanzo storico, come genere, si è ramificato in modo notevole, negli ultimi otto o dieci anni.
È lontana l’arcadia candida e un po’ strettina in cui Sir Walter Scott, Dumas e Manzoni, con i loro seguaci, imitatori ed epigoni, esaurivano più o meno il panorama. C’era l’ambientazione in secoli passati, c’era una guerra/battaglia/pestilenza/cospirazione/sollevazione armata, c’era una maggiore o minore libertà rispetto alle fonti, c’era un malvagio destinato alla sconfitta, c’era una giovane coppia destinata all’altare, et voilà: romanzo storico.
Per molto tempo, l’unica distinzione era stata quella tra romanzi storici e romanzi storici per fanciulli – alle volte con risultati bizzarri: sapete tutti che questo è a pet peeve of mine, ma davvero: chi può voler considerare Il Signore di Ballantrae di Stevenson un romanzo per fanciulli?).
Arcadia, come dicevo: adesso si può contare facilmente una decina di sottogeneri.
1. Romanzo rosa storico. Oppure romanzo storico rosa, a scelta. E sì, lo so: tutti pensiamo subito a qualche Harmony in cui personaggi dalla mentalità e dal comportamento contemporanei indossano costumi di un’epoca a scelta, e questo è quanto. Ad ovest della Manica, in realtà, si trovano commercializzati come historical romance dei romanzi di caratura molto superiore (per qualità di scrittura e accuratezza di ambientazione), che da noi sfuggirebbero alla classificazione “rosa”, ma in cui l’elemento sentimentale ha un’importanza prevalente.
2. Fantasy storico. Probabilmente, il caso più famoso è il bellissimo Jonathan Strange & il Signor Norrel, di Susanna Clarke, che ipotizza l’impiego della magia a fini militari nel corso delle guerre napoleoniche. Personalmente, trovo irresistibile l’idea dei maghi dell’esercito inglese impegnati a spostare colline, strade, fiumi e villaggi della Spagna per confondere le idee ai Francesi! Ad ogni modo, si tratta di trame che associano elementi fantastici agli avvenimenti storici, oppure creano mondi immaginari basati su un periodo storico. Se vogliamo, il Calvino de Il Cavaliere Inesistente ricade in questo genere. All’interno del quale, in teoria, bisognerebbe distinguere…
3. Horror storico, il cui punto di forza sono gli onnipresenti vampiri, calati in un’epoca a scelta*. Pensate a Intervista con il Vampiro di Anne Rice – ma non dimenticherei nemmeno licantropi, zombie e streghe.
4. Giallo storico. Questo non ha quasi bisogno di spiegazione: delitti e indagini in qualche epoca passata. Citiamo Il Nome della Rosa di Umberto Eco, e anche le indagini di Fratello Cadfael di Ellis Peters. Persino Agatha Christie si lasciò tentare, già nel 1945, ambientando C’era una volta (Death comes as the end) nell’antico Egitto. Una variante particolarmente fortunata di questo genere vede personaggi storici all’opera come detectives – e per un esempio italiano citerò La Sposa di Annibale, di Guglielmo Colombero – ma la produzione in questo campo è molto varia – dal fratello di Shakespeare a Jane Austen, da Abigail Adams al Dr. Johnson…
5. Romanzo storico militare. Anche questo è piuttosto autoevidente: protagonisti militari e abbondanza di guerre e battaglie. Bernard Cornwell e Valerio Massimo Manfredi rientrano in questo genere. Un sottogenere è costituito dalla cosiddetta Naval Fiction. Ne abbiamo parlato di recente.
6. Multiperiod. Romanzo che alterna vicende accadute in secoli diversi, e più o meno correlate tra di loro. Mi viene in mente il (mediocre) The Intelligencer, di Leslie Silbert, i cui capitoli si dividono tra la Londra elisabettiana di Christopher Marlowe e la Washington contemporanea, con lo stesso mistero al centro. Se posso essere spudorata, il mio Lo Specchio Convesso insegue l’elusivo Ammirabile Critonio tra la Mantova cinquecentesca, la Scozia del XVII Secolo e la Londra di Dickens. Diverso da…
7. Saga familiare, che segue diverse generazioni della stessa famiglia attraverso il corso degli anni (o dei secoli). Rilevante ai nostri fini quando gli anni in questione appartengono a qualche passato, come i cicli dei Courteney e dei Ballantynes di Wilbur Smith e, più vicino a noi, La Spilla di Janesich, di Antonio Della Rocca.
8. Viaggio nel tempo. Il nostro eroe, per un motivo qualsiasi, volutamente o per caso, si ritrova in un’epoca diversa dalla sua. I risultati possono variare dalle buffe complicazioni (il capostipite è forse Un Americano alla Corte di Re Artù, di Mark Twain), ai cavoli amari, come in Timeline, di Michael Chricton.
9. Romanzo storico per ragazzi. Citiamo R.L. Stevenson con Il Ragazzo Rapito e Lino Piccolboni con I Cannoni di Venezia, autore e titolo che, per una volta ci consentono di sorvolare sul modo in cui, negli autori italiani di questo sottogenere, l’ansia per il politically correct nuoce al rigore storico.
10. Ucronia. Ovvero, ipotesi di storia alternativa. Il re del genere è Harry Turtledove, il cui romanzo ucronico più conosciuta in Italia forse è Per il Trono d’Inghilterra, ma c’è, per esempio, Roberto Farneti, con la saga di Occidente.
Il mercato americano distingue ancora almeno due sottogeneri: il western storico (devo spiegarlo davvero?) e il romanzo storico cristiano (a forte contenuto spirituale), che in Italia praticamente non esistono. E si possono aggiungere ancora le “psedudostorie”, come L’Isola del Giorno Dopo di Eco, o Il Viaggio dell’Elefante di Saramago, che narrano avvenimenti storici filtrati attraverso una voce autoriale moderna o a-storica.
Se non bastasse, esistono poi romanzi che mescolano vari sottogeneri. Il Teschio di Cristallo di Manda Scott (sì, quello…) è un multiperiod con forti elementi fantasy e una trama pseudogialla. Personalmente non mi azzarderei a definirlo un romanzo storico, ma è pur vero che per metà si svolge nel Cinquecento, e quindi, per dire, rientra nei criteri di HNR, che peraltro lo ha recensito, seppur senza eccessivo entusiasmo.
Insomma, il romanzo storico, come tutti i generi letterari, è in continua evoluzione, in una dialettica continua tra sperimentazione e mercato. E, tornando alla domanda iniziale, che bisogna fare di questa fioritura fuori dalle aiuole?
Ecco, a me sembra che la fioritura sia qui per restare, e che volerla ignorare sia un genere di esercizio singolarmente futile – oltre che miope. A che serve rinchiudere un genere letterario in un quadratino? A mio timido avviso il discrimine è altrove, tra il tentativo di ritrarre in modo onesto e plausibile i modi, gli usi e la mentalità di un’epoca e le collezioni di anacronismi psicologici in crinolina – ma anche questa è una valutazione d’altro tipo, che non può funzionare come criterio pratico per la delimitazione del genere…
E allora trovo ragionevole la definizione di HNR:
Per essere considerato storico ai nostri fini, un romanzo deve essere stato scritto almeno 50 anni dopo gli eventi narrati, o da qualcuno che non era vivo all’epoca in cui gli eventi si sono svolti, e quindi le conosce soltanto attraverso la ricerca.
E la distanza di cinquant’anni può essere arbitraria, ma in fondo è tutto quel che serve: al di là di quel limite c’è spazio per tutte le evoluzioni, gli esperimenti, le ibridazioni e le ipotesi che possono mantenere vivo il genere.
________________________________________________________
*Non credo che sia stato tradotto in Italiano, ma esiste un ciclo di romanzi che ritraggono il Barone Rosso e i suoi piloti come una squadriglia di supervampiri… giuro!
 libri, libri e libri, romanzo storico
libri, libri e libri, romanzo storico  3 Comments
3 Comments 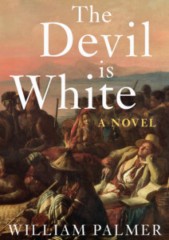 Avviso ai naviganti: Libro Non Tradotto ahead.
Avviso ai naviganti: Libro Non Tradotto ahead.