 grilloleggente, libri, libri e libri, romanzo storico, teorie
grilloleggente, libri, libri e libri, romanzo storico, teorie  8 Comments
8 Comments Violento E Brutale
 Sono lievemente sconcertata.
Sono lievemente sconcertata.
Nella frenesia da andata in stampa imminente dell’ultimo numero di HNR, mi sono vista affibbiare d’autorità un libro che forse di mio non avrei letto, The Splintered Kingdom di James Aitcheson – secondo volume di quella che diventerà, mi par di capire, una trilogia.
E mi è andata bene, perché perché ci ho guadagnato una piacevole lettura. Avventure alla vecchia maniera nell’Inghilterra post Hastings, con un punto di vista normanno (che non è cosa di tutti i giorni), un sacco di battaglie, imboscate, tradimenti, intrighi e un protagonista benintenzionato con un talento per mettersi nei guai.
Il mezzo bretone Tancred a Dinant vorrebbe tanto essere un buon neosignore del maniero, un buon vassallo, un buon cristiano – ma è troppo ambizioso, collerico e ostinato per non farsi nemici ad ogni passo, e così…
E per di più Aitcheson non scrive per niente male: ha buon ritmo, descrive e caratterizza con efficacia, ha fatto le sue ricerche e le dispensa con giudizio. E per di più ancora, i suoi personaggi hanno idee, certezze, priorità e pregiudizi da XI Secolo.
Insomma, mi è piaciuto abbastanza perché, dopo averlo finito, abbia ceduto all’uzzolo di ordinare subito il primo volume.
E così scrivo una buona recensione per HNR e, nell’atto di spedirla, mi accorgo di avere gettato con troppo entusiasmo la sovraccoperta,* e di non sapere più il prezzo dello hardback, che devo indicare tra i dati del volume.
La cosa semplice da farsi è controllare su Amazon e, già che ci sono, butto un’occhiata alle recensioni. Ce ne sono poche – il libro è appena uscito in Inghilterra e non ancora in America – per lo più entusiastiche. Ma in diverse appare un caveat: il libro è molto violento. Le scene di battaglia sono truculente. La prosa di Aitcheson è brutale. High octane stuff, dice un recensore – e magari non emerge come caratteristica primaria del libro, ma ritorna abbastanza da notarsi.
Ed è qui che mi sconcerto, perché lo sapete che sono squeamish. Non solo ho i miei problemi con la fantascienza, e l’horror è al di là delle mie possibilità, e non leggo storie di fantasmi dopo il tramonto**, ma anche le descrizioni di violenze, torture, battaglie e sanguinosità varie assortite, quando virano sul grafico, mi danno un certo qual mal di stomaco.
Ma con TSK non è successo nulla del genere.
Be’, ok, non c’è nulla di edulcorato, Aitcheson non rifugge gli aspetti meno gradevoli della vita (e morte) nell’XI Secolo – ma non ci sguazza nemmeno. E nonostante il sottotitolo sia 1066: the bloody aftermath, davvero non c’è nessuna truculenza insistita o gratuita. Al punto che persino io posso leggere senza riportarne traumi duraturi…
E allora? Che cos’è che scuote tanto la sensibilità di questi lettori britannici? Che poi sia chiaro, anche loro apprezzano il libro, ma lo individuano come particolarmente violento. Perché mai in cielo e in terra?
E, scartando l’idea di avere sviluppato una nuova soglia di tolleranza al sangue stampato, sono giunta a formulare un’ipotesi.
Il fatto è che Tancred, narratore in prima persona, non mostra la minima remora in fatto di battaglie, uccisioni e spargimento di sangue. Fa quel che è stato addestrato a fare fin da ragazzino con entusiasmo dichiarato e con la certezza di essere nel giusto. Quando non ha modo di andare in battaglia per un po’, ne sente la mancanza. Certo il muro di scudi è una faccenda pericolosa, truce e brutale, certo i nemici fanno più che sul serio, certo si muore, si perdono amici e compagni d’armi, certo gli errori di giudizio, i rovesci della sorte, la paura, l’occasionale sconfitta, la fatica – ma ah, the battle-joy!
Non una volta in quattrocento pagine Tancred attraversa una di quelle crisi di disgusto post-battaglia. La guerra è il suo mestiere, unashamedly. Ed è bravo in quel che fa, e forse ha sviluppato una certa qual dipendenza da adrenalina – anche se di sicuro non la chiama così – e quasi gli dispiace per la gente che non conosce le gioie pericolose della “via della spada.”
Assai poco politically correct, di sicuro.
E allora mi domando se non sia questo il punto – non tanto la violenza in sé, quanto un atteggiamento di fronte alla violenza. Questo gusto della battaglia senza remore e senza un briciolo di condanna, che su di noi gente civilizzata esercita il suo fascino high octane, ma al tempo stesso ci sembra (o quanto meno sentiamo che deve sembrarci) spaventosamente riprovevole, brutale e barbarico?
___________________________________________
* Ho un’avversione per le sovraccoperte. Non m’importa quanto siano ben riuscite, la prima cosa che faccio quando vengo in possesso di un libro in hardback, è liberarmi della sovraccoperta. Se leggo hardback in prestito, tolgo la sovraccoperta mentre leggo, e la rimetto a posto con ogni cura a lettura avvenuta. La sovraccoperta m’intralcia, mi irrita, s’infila dove non dovrebbe.
** Anche se, apparentemente, non ho il minimo problema a scriverne dopo il tramonto. Dev’essere un equivalente letterario del non avere il mal d’auto quando si guida, I guess…

 Sono o non sono anni che vi dò il tormento a proposito di Josephine Tey?
Sono o non sono anni che vi dò il tormento a proposito di Josephine Tey? 
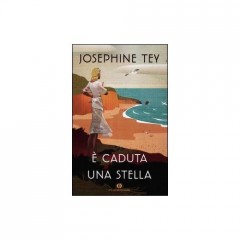 E naturalmente indaga in quell’Inghilterra che non c’è più – e chissà se ci sia mai stata fino in fondo, ma mi piace pensare di sì – in cui si prende il tè alle cinque, i landruncoli cockney chiamano tutti guv’nor e le celebri attrici portano guanti al gomito e cappelli a tesa larga, un’Inghilterra fatta di paesini di campagna e strade londinesi, teatri shakespeariani e magioni della buona, vecchia e solida gentry. Un’altra celebre giallista, P.D. James, dice che tutto ciò fa dei gialli teyiani quasi dei romanzi storici, con la loro “rievocazione di un’epoca gentile, pacifica e rispettosa delle gerarchie.***” E P.D. James, dopo tutto, quel mondo lo ha conosciuto… quindi forse, almeno in parte è esistito.
E naturalmente indaga in quell’Inghilterra che non c’è più – e chissà se ci sia mai stata fino in fondo, ma mi piace pensare di sì – in cui si prende il tè alle cinque, i landruncoli cockney chiamano tutti guv’nor e le celebri attrici portano guanti al gomito e cappelli a tesa larga, un’Inghilterra fatta di paesini di campagna e strade londinesi, teatri shakespeariani e magioni della buona, vecchia e solida gentry. Un’altra celebre giallista, P.D. James, dice che tutto ciò fa dei gialli teyiani quasi dei romanzi storici, con la loro “rievocazione di un’epoca gentile, pacifica e rispettosa delle gerarchie.***” E P.D. James, dopo tutto, quel mondo lo ha conosciuto… quindi forse, almeno in parte è esistito. 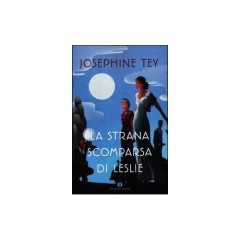

 È successo di nuovo.
È successo di nuovo.