Quello che non arrivo a capire, alla fine fine, è se Gene Ayres si prenda davvero tanto sul serio come appare da questa intervista rilasciata a Lucius Etruscus di Thriller Magazine, oppure se anche l’immagine del martire antistratfordiano faccia parte dell’operazione di marketing.
Gli antenati quaccheri, il fratello maggiore fisico dedito alla ricerca della verità, i ritrovamenti sensazionali, la persecuzione da parte degli ambienti accademici, il muro di gomma editoriale… Tutto molto drammatico, no? Non siete già curiosi di leggere il frutto di tanta audace originalità e coraggiosa dedizione?
Può darsi che lo siate, e così lo leggete, e scoprite che in realtà quello che Gene Ayres (sotto lo pseudonimo di John Underwood) vi ha propinato è un thrillerino debolissimo e pasticciato, farcito d’improbabilità narrative e di teorie vecchie come le colline…
E badate, questo non è un rant stratfordiano. Non ho nessun particolare affetto per la tesi che Shakespeare e nessun altro abbia scritto le opere di Shakespeare – pur trovando serie difficoltà nella maggior parte delle tesi alternative. Diciamo che in proposito sono agnostica. Semmai, sono pronta ad ammettere che la questione del Vero Autore è ottima materia da romanzi – però mi aspetto di vederla trattata in almeno uno di due modi: o convincente, o sottile. Possibilmente entrambi. Gene Ayres/John Underwood, temo, manca gravemente in entrambi i campi, e non si riscatta nemmeno con una trama gialla di qualche solidità.
Ora, cominciamo col dire che scrivere un giallo letterario significa avventurarsi in territorio pericoloso. Si tratta di rendere avvincente una vicenda in cui qualcuno passa un sacco di tempo disseppellendo minuti dettagli da manoscritti polverosi – attività emozionante per il seppellitore, ma potenzialmente noiosissima per chi ne legge.
Da questo punto di vista, ILSdS rende omaggio al ben altrimenti incantevole La Figlia del Tempo, di Josephine Tey (capostipite del genere e nume letterario del riccardianesimo) in cui, dal suo letto d’ospedale, un ispettore capo di Scotland Yard dirige come un’indagine la ricerca che porterà a stabilire l’innocenza di Riccardo III. Tey riesce, in un miracoloso equilibrio di tensione, tempi perfetti e dialoghi scintillanti, a creare suspence senza far scorrere una goccia di sangue – oltre a quello già versato nella Torre, si capisce. Ayres/Underwood allude a Tey implicitamente ed esplicitamente*, ma poi non è capace di fare altrettanto bene.
Concediamo pure che le dimensioni quadruple e i ripetuti omicidi fossero scelte pressoché obbligate. Nel mondo anglosassone non si vende nulla al di sotto delle 90000 parole, ed è obiettivamente più facile creare tensione quando il protagonista rischia la vita. Peccato che, nell’ansia di creare tensione, Ayres** si sia lasciato prendere un tantino la mano…
E ADESSO, PER FAVORE, FERMATEVI SE NON VOLETE SAPERE COME VA A FINIRE IL LIBRO. QUESTA NON È UNA RECENSIONE: È UNA SPIETATA DISSEZIONE, CON ABBONDANTE ESPOSIZIONE DI ORGANI INTERNI. RIPRENDETE A LEGGERE DAL TERZ’ULTIMO PARAGRAFO E POI TORNATE QUI QUANDO AVRETE LETTO IL LIBRO E CONSTATATO DA VOI.
Ecco – e poi non dite che non vi avevo avvertiti.
Per chi è ancora qui, onwards. Ayres, dicevo, si lascia prendere la mano e dissemina Malvagi come se piovesse. C’è uno studioso shakespeariano alquanto deranged, che si aggira per due continenti nuocendo variamente a rivali accademici e conversando per citazioni del Bardo. Poi c’è una bieca multinazionale offshore, disposta a misure tanto drastiche quanto bizzarre per proteggere i suoi cospicui profitti shakespeariani. E poi c’è Scotland Yard, il cui comportamento nel proteggere gli’interessi nazionali legati al nome dello Zio Will è, nella più benevola delle ipotesi, ambigua. E potremmo aggiungere intere facoltà di letteratura inglese pervicacemente decise a condonare persino l’omicidio, se si tratta di proteggere il nome del Bardo…
E non è come se il campo dei buoni fosse meno confuso. C’è la vittima sacrificale, un eccentrico professore universitario cui Ayres attribuisce la sua ricerca “originale” – o meglio, ci sarebbe, perché costui scompare presto. Poi c’è il protagonista, un giornalista investigativo americano provvisto delle più pallide e superficiali competenze in fatto d’Inghilterra elisabettiana – ideale come veicolo per treni merci di esposizione in materia, perché bisogna spiegargli tutto, ma proprio tutto. Poi ci sono i suoi supposti aiutanti: la figlia laureata in letteratura inglese e decisa a diventare attrice***, un fisico indiano, co-cospiratore del defunto, e un anziano libraio. Ora, il fatto è che tutti costoro hanno memoria selettiva e una natura lievemente sadica. La bella figlia**** ha studiato un sacco di letteratura elisabettiana, ma i nomi di Greene, Nashe e persino Marlowe non le dicono praticamente nulla per tre quarti del libro. Per di più è in (innocente?) combutta con l’assassino, che pure le ha praticamente confessato i suoi misfatti. Il fisico indiano è fisico in omaggio al fratello dell’autore, ed è indiano per giocare meglio il ruolo dell’outsider. A parte questo, è un complottista paranoico di dubbia utilità personale e narrativa e, si scoprirà poi, a sua volta in combutta con Scotland Yard. Il libraio, invece, pur avendo la chiave di tutta la faccenda, centellina le sue informazioni come se si trattasse di una caccia al tesoro, lasciando che il protagonista rischi la vita e perda il sonno strologando su una puerile lista di abbreviazioni trovata – hear ye! hear ye! – nella tasca di una giacca dimenticata dal defunto in tintoria!
Il risultato si è che il nostro giornalista investigativo, assistito da ben tre esperti di cose elisabettiane, impiega duecentocinquanta pagine a scoprire l’esistenza di teorie alternative sul Vero Autore. E adesso fate un piccolo esperimento, o Lettori. Aprite Google, impostate l’Inglese come lingua di ricerca e poi cercate William Shakespeare. Il primo risultato è la relativa voce Wiki, che al paragrafo 7 introduce la questione del Vero Autore e rimanda a tutta una serie di dettagliatissimi lemmi in proposito – ma provate ad aprire gli altri risultati nella prima pagina, e constatate la quasi onnipresenza della Authorship Question… Fatto ciò, supponendo che vi sia sorta qualche curiosità (immaginate, per esempio, che il vostro amico sia stato assassinato di recente – prima di pubblicare un controverso saggio sul Bardo…) e cercate Authorship Question. Fatto?
E allora, avete impiegato la bellezza di un paio di minuti a scoprire il grande segreto che Ayres/Underwood/Lewis sostiene di avere rivelato per primissimo sfidando secoli di bieco e mercenario (per non dire potenzialmente pericoloso) oscurantismo.
Perché, o Lettori, la questione può sembrare di lana caprina da questo lato della Manica, ma nel mondo anglosassone ci si scanna con grande energia su chi abbia scritto le opere di Shakespeare – fin dalla fine dell’Ottocento. Con grande energia e in tutta libertà, bisogna dire, perché non mi risulta che nessuno abbia mai attentato per questo alla vita di Delia Bacon, Mark Twain, Hawthorne, Calvin Hoffman, Freud, Archie Webster o Antonia Wright – tanto per citare solo qualche antistratfordiano di punta. Why, esistono e prosperano decine di associazioni internazionali dedicate a sostenere le pretese dell’uno o dell’altro candidato, e nel 1993 la Marlowe Society è riuscita a far aggiungere un punto di domanda accanto alla data di morte del suo beniamino nel Poet’s Corner dell’Abbazia di Westminster.
Ora, non dubito che tutta questa gente si sia attirata (e abbia ricambiato) molta furiosa e/o sprezzante acidità da parte degli ambienti accademici, ma mi pare che l’idea di cospirazioni del silenzio, pubblico ignaro, attentati oscurantisti e minacce semiufficiali per soffocare una teoria marloviana sfiori molto da vicino il ridicolo. E questo, a mio timido parere, è il motivo principale per cui nessun editore americano o inglese ha voluto pubblicare The Shakespeare Chronicles: da un lato i romanzi marloviani abbondano, e dall’altro questo è basato su premesse improponibili. Non tanto l’ipotesi che Marlowe abbia scritto le opere di Shakespeare (che circola, in forma di saggio e di romanzo, fin dal lontato 1894), quanto l’idea che l’ipotesi in questione possa essere pericolosa, scandalosa, inaudita o ignorata da chiunque abbia mai sentito nominare Marlowe… Fuori dal mondo anglosassone il problema appare più remoto e più ignoto – ed ecco le sette edizioni in altre lingue.
NOTA DI SERVIZIO: CHI SOFFRE DI ALLERGIA AGLI SPOILER PUO’ RIPRENDERE A LEGGERE DA QUI.
Poi, tornando all’intervista, si scopre che Ayres ha cercato di presentare le sue teorie in forma di saggio – ricevendo ripetutamente il due di picche. Allora ne ha fatto un romanzo, cui ha accostato una ripubblicazione del saggio originale sotto il nome di Desmond Lewis – guarda caso l’assassinato del romanzo. il saggio non l’ho letto, ma il romanzo (così come l’intervista) è condito di molta bile nei confronti degli Ayatollah Accademici, ovvero tutti gli studiosi shakespeariani che avrebbero a) abbracciato, avallato e perpetuato una secolare congiura di calunnie a proposito del povero, candido, innocente, virtuoso Kit Marlowe; b) rifiutato le argomentazioni di Ayres solo perché lui non è un accademico; c) appoggiato la congiura editoriale che non gli ha consentito di trovare un editore.
L’idea di avere scoperto l’acqua calda e di averla rifritta in un thriller mediocre, pare non sfiorarlo. Così come non lo sfiora il dubbio che le inesattezze storico-letterarie possano avere nuociuto alla sua credibilità. Affermare che Thomas Kyd era uno degli University Wits, o che Francis Walsingham era il nonno di Lady Mary Sidney***** non è il genere di exploit che ti fa prendere sul serio in ambito accademico. E il bello è che nell’intervista Ayres ringrazia l’editor italiana di Newton Compton che gli ha segnalato “alcuni errori importanti.” Non oso pensare******.
Insomma, in tutto questo, l’unico aspetto vagamente interessante del libro – l’ipotesi (improbabile e non provata, ma non peggiore di tante altre) che il Bel Giovane dei Sonetti sia un figlio illegittimo dell’autore, anziché un amante – finisce soffocata in una farragine di assurdità, esposizione, scrittura mediocre, inesattezze, coincidenze e pretese di originalità, senza nemmeno l’ombra di un finale*******. E paradossalmente, almeno ai miei occhi, il voler dipingere l’autore come un martire letterario/accademico è l’aspetto più irritante dell’insieme. Se è marketing, è proprio bieco. Se è self-righteousness, è tanto ingiustificata quanto insopportabile.
_______________________________________________________
* Mi domando se il riferimento esplicito non sia stato aggiunto per la pubblicazione nei paesi non anglofoni. Credo che il lettore medio anglosassone difficilmente potrebbe non notare la linea di discendenza.
** Ne ho abbastanza di scrivere Ayres/Underwood, perdonate…
*** Altra strizzata d’occhio a Tey, la cui coprotagonista Marta Hallard è, appunto, un’attrice teatrale.
**** E quanto tempo passa il padre a compiacersi della bellezza, intelligenza, astuzia, determinazione e forte personalità di questa figlia…
***** Ma c’è parecchia confusione in proposito, perché in un altro passaggio la vedova di Sir Philip Sidney (fratello di Lady Mary) divenda la sorella di Walsingham, del quale invece era figlia.
****** Oh, e già che ci siamo, nota di biasimo anche per le traduttrici. Questo non è un saggio con un apparato critico colossale e note a pie’ di pagina nell’ordine delle migliaia. I dettagli non sono così tanti da non poterli controllare – e, se è abbastanza ovvio che Calvin Hoffman e Archie Webster sono uomini, perché la povera Una Mary Ellis-Fermor deve diventare “lo studioso inglese U.M. Ullis-Fermor”? A parte tutto il resto, quanti nomi maschili inglesi ci sono che cominciano per U? E sì, d’accordo: è un rant. Ho solo detto che non sarebbe stato un rant stratfordiano, no?
******* But fear not (oppure fear a lot, dipende dai punti di vista): Ayres/Underwood sta già lavorando al seguito.
 anglomaniac, grilloleggente, guardando la storia
anglomaniac, grilloleggente, guardando la storia  5 Comments
5 Comments  Verrebbe da pensare che sia tutta questione di nomi.
Verrebbe da pensare che sia tutta questione di nomi.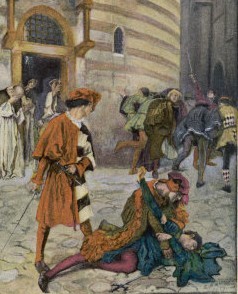

 Avrei creduto che la Francia si scuotesse un po’ di più per il seicentesimo anniversario della nascita di Giovanna d’Arco, ma si direbbe che la contadinella-soldato, la piccola coronatrice di re con le voci e le visioni sia un po’ passata di moda – senza per questo avere mai smesso di ispirare legioni scrittori dentro e fuor di Francia.
Avrei creduto che la Francia si scuotesse un po’ di più per il seicentesimo anniversario della nascita di Giovanna d’Arco, ma si direbbe che la contadinella-soldato, la piccola coronatrice di re con le voci e le visioni sia un po’ passata di moda – senza per questo avere mai smesso di ispirare legioni scrittori dentro e fuor di Francia. 
 Naturalmente non ci si può aspettare nulla del genere da George Bernard Shaw, e però la sua Saint Joan è a suo modo quasi altrettanto singolare. Qui abbiamo una ragazzina ignorante e piena di buon senso, che trascina soldati, capitani e re per pura incrollabilità di proposito, pur restando del tutto umana. Candida, sensata e devota, la Pulzella (“Ma in Lorena mi chiamano Jenny”) sale al rogo con i suoi dubbi di proto-protestante e la sua fede, e torna – in spirito o in sogno – a discutere con Carlo VII.
Naturalmente non ci si può aspettare nulla del genere da George Bernard Shaw, e però la sua Saint Joan è a suo modo quasi altrettanto singolare. Qui abbiamo una ragazzina ignorante e piena di buon senso, che trascina soldati, capitani e re per pura incrollabilità di proposito, pur restando del tutto umana. Candida, sensata e devota, la Pulzella (“Ma in Lorena mi chiamano Jenny”) sale al rogo con i suoi dubbi di proto-protestante e la sua fede, e torna – in spirito o in sogno – a discutere con Carlo VII.